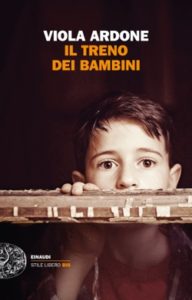Nella Napoli popolare del 1946, il piccolo Amerigo ha 7 anni e un gioco segreto: “Guardo le scarpe della gente. Scarpa sana: un punto; scarpa bucata: perdo un punto. Senza scarpe: zero punti. Scarpe nuove: stella premio”. Lui di scarpe sue non ne ha mai avute, porta quelle degli altri, che gli fanno male e lo fanno camminare storto; d’altronde, le scarpe degli altri “che ne sanno di come cammino io e di dove voglio andare?”. Non è solo un gioco scaramantico, il suo: è la prima, embrionale intuizione che non è facile adattarsi a quello che già c’è, che per alcuni può essere una sofferenza vivere nella forma, nei modi, con i mezzi che il mondo in cui sono nati offre loro. E il suo mondo non gli offre molto: una madre, Antonietta, brusca, poche parole e molte preoccupazioni, poco avvezza alle manifestazioni di affetto, un padre mai conosciuto che forse è in America a fare soldi, nessuna scuola, una vita per strada, tra i vicoli, il lavoro al mercato e gli amici, pochissimo di tutto e comunque raccimolato con fatica. Ma Amerigo è un bambino sveglio, vivace, pieno di risorse e di spirito; non per niente di cognome si chiama Speranza. Le difficoltà non lo demoralizzano. Il suo racconto, tutto in prima persona, è divertente, innervato da una saggezza candida e spiccia ben restituita da una lingua colorita, scoppiettante, ricca di inflessioni dialettali.
In questo contesto di povertà e disagio dell’immediato dopoguerra, prende forma l’iniziativa del Partito Comunista di offrire un’opportunità a questi figli del popolo. Così, le donne comuniste radunano le madri, spiegano, le convincono un po’ alla volta e infine organizzano dei treni che portano i loro figli al Nord. Qui, in un ambiente completamente diverso, meno provato dalla guerra, i bambini verranno ospitati per diversi mesi da famiglie che si sono offerte volontarie e si occuperanno di sfamarli, vestirli, mandarli a scuola. Staccarli dalle loro famiglie non serve solo a sottrarli temporaneamente alla miseria, ma permette loro di ricevere un accudimento e un’istruzione che a casa non possono avere. È un esperimento di solidarietà tra le varie regioni di Italia che vuole spezzare un circolo vizioso, perché “la fame non è una colpa ma un’ingiustizia” e le cose possono migliorare solo dandosi una mano.
Amerigo, insieme a centinaia di altri bambini, sale sul treno con un misto di curiosità, speranza e paura. Finirà a Modena e presto la nostalgia della madre verrà affiancata (ma non soppiantata) da un affetto sempre più forte per le persone generose e amorevoli che si occupano di lui. Grazie alle loro attenzioni, Amerigo scoprirà i propri talenti e crescerà. Perché oltre a pasti regolari e vestiti comodi riceve anche, per la prima volta, incoraggiamenti, gratificazioni, nuove idee, stimoli grazie a cui la sua intelligenza e il suo carattere possono sbocciare.
Il libro si divide sostanzialmente in due parti: la prima copre il periodo che precede e segue l’esperienza settentrionale, con i suoi vissuti e i suoi cambiamenti; la seconda racconta un momento cruciale nella vita dell’Amerigo ormai uomo maturo. Le pagine si stagliano sullo sfondo di un momento storico importante e ne offrono un interessante spaccato. È un’Italia divisa a metà, con paesaggi diversi, lingue diverse, riferimenti diversi e la Napoli urbana è agli antipodi dell’Emilia-Romagna rurale. Ma questo non è un romanzo politico, è un romanzo di sentimenti. Le emozioni passano facilmente dalla pagina al lettore, che si diverte e si intenerisce, spera, teme, resta deluso, si immalinconisce. La prospettiva infantile, che potrebbe essere di inciampo, è qui sfruttata molto bene. La voce dell’io narrante, Amerigo, è uno dei pregi del libro. Il suo stile mima il parlato e cambia con il crescere del protagonista, perdendo progressivamente la parte più dialettale, arricchendo il lessico e sviluppando la sintassi.
Il suo sguardo non restituisce solo ciò che questo viaggio porta di buono, ma anche ciò che esso distrugge: i nuovi legami non si limitano ad aggiungersi ai precedenti, ma li intaccano in profondità, le nuove esperienze non sono un bagaglio neutro, non portano solo a un arricchimento, a una trasformazione positiva, ma anche all’impossibilità di tornare veramente indietro. Quando, mesi dopo, i bambini riprenderanno il treno per Napoli, saranno ormai “spezzati in due metà”. Per alcuni il dissidio potrà ricomporsi, per altri la cesura sarà definitiva e, prima o poi, sarà necessario fare il bilancio tra ciò che si è guadagnato e ciò che si è perso e ricucire ciò che si è lasciato in sospeso.
Francesca